Sudafrica on the road: noi un pezzo di mondo in un van sulla Garden Route

 Ci avevano piazzato in un van senza sapere quali fossero i nostri punti di contatto. L’unica cosa che sapevamo erano le nostre provenienze: Italia, Inghilterra, Olanda, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Sudafrica. Quando percorri in lungo e largo la Garden Route, fioriera sudafricana tra Western e Eastern Cape, ti immergi dietro un sipario della natura.
Ci avevano piazzato in un van senza sapere quali fossero i nostri punti di contatto. L’unica cosa che sapevamo erano le nostre provenienze: Italia, Inghilterra, Olanda, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Sudafrica. Quando percorri in lungo e largo la Garden Route, fioriera sudafricana tra Western e Eastern Cape, ti immergi dietro un sipario della natura.
Tra una remata e l’altra in quella canoa lungo uno dei fiumi del Garden Route National Park avevo trovato briciole della storia personale di Gareth, la nostra guida, infanzia e adolescenza a Port Elizabeth, nonna scozzese, una nuova vita a Città del Capo.
La natura ti fa ritrovare i tuoi simili, perché durante una lunga scarpinata, incantato di fronte a un panorama, ascoltando la voce fragorosa dell’oceano puoi riconoscere chi affronta la quotidianità con quel pizzico di strafottenza e legarti inevitabilmente a lui.
Quei duemila chilometri on the road assieme a Gareth, Sue, Eddy, Hanne, Bodhi, Lana e Sarah, mi avevano restituito il clima di condivisione tipico dei tempi in cui vai via da casa e ti barcameni in uno stile di vita autonomo.
La casa di Mark a Sedgefield era diventata, nel giro di qualche giorno, il punto di partenza e ritorno dalle nostre scorribande. Mark, nato e cresciuto a Johannesburg, era un perfetto padrone di casa: ospitale, accogliente, capace di preparare ghiottonerie con pochi giochi di prestigio ai fornelli.
Era la sera, dopo cena, sotto le stelle del Western Cape che ci aprivamo sorseggiando un bicchiere di vino, eravamo così lontani geograficamente ma vicini nel nostro modo di essere, frantumando le pareti che, a differenza di tanti, non ci hanno mai sottratti all’essenza di crescere come autentci esploratori della libertà.
Ci sentimmo un pezzetto di mondo, dentro e fuori quel van, guardando diritto negli occhi il crepuscolo oceanico di Jeffreys Bay, sperando che tutto questo non finisse mai. L’ingrata consapevolezza da quarantenne che non avrei rivisto più Gareth, Sue, Eddy, Hanne, Bodhi, Lana e Sarah fece improvviso spazio alla lucida speranza del instancabile viaggiatore: non li avrei dimenticati mai più.
Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. (J. Steinbeck)




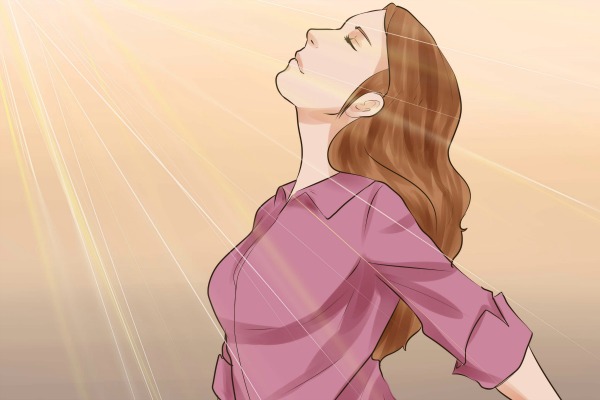



 Non occorre essere anticlericali fino alle unghie dei piedi per strillare col megafono che don Riccardo Seppia rappresenta il disonore del sacerdozio. Il parroco di Sestri Ponente è accusato di abusi sessuali sui minori, ma peggio ancora si trema dinanzi alla notizia shock: il “don mostro” è anche sieropositivo e potrebbe aver contagiato chissà quali delle sua vittime.
Non occorre essere anticlericali fino alle unghie dei piedi per strillare col megafono che don Riccardo Seppia rappresenta il disonore del sacerdozio. Il parroco di Sestri Ponente è accusato di abusi sessuali sui minori, ma peggio ancora si trema dinanzi alla notizia shock: il “don mostro” è anche sieropositivo e potrebbe aver contagiato chissà quali delle sua vittime.