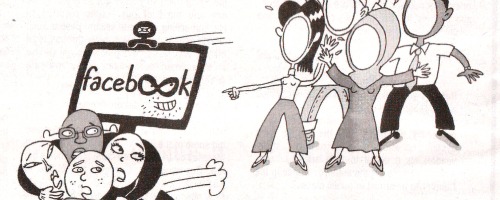Sotto l’albero di Natale tra Blake Edwards e Audrey Hepburn

![]() Alle mie spalle c’è l’albero di Natale che fa luce nel buio. Alla mia sinistra campeggia la locandina di Colazione da Tiffany, con Holly (la protagonista del film) che prende forma in un regolare disegno. Escono dallo schermo televisivo a 40 pollici Audrey Hepburn e George Peppard e mi sembra di toccarli con mano. Niente effetti 3D, ma semplicemente un DVD della copia restaurata di Colazione da Tiffany. Ma ci rendiamo conto: questa è roba di mezzo secolo fa, ma l’effetto è stupefacente. Audrey canticchia Moon River e io alzo il volume del Dolby Surround. I vicini protestano ed io faccio finta di niente. Com’è possibile che sia così deliziosa? Certo regale in Vacanze Romane, elegante in Cerenentola a Parigi, canterina in My Fair Lady, di classe in Sabrina, ma in questo film è diversa dal solito. Sarà pure la mano del regista.
Alle mie spalle c’è l’albero di Natale che fa luce nel buio. Alla mia sinistra campeggia la locandina di Colazione da Tiffany, con Holly (la protagonista del film) che prende forma in un regolare disegno. Escono dallo schermo televisivo a 40 pollici Audrey Hepburn e George Peppard e mi sembra di toccarli con mano. Niente effetti 3D, ma semplicemente un DVD della copia restaurata di Colazione da Tiffany. Ma ci rendiamo conto: questa è roba di mezzo secolo fa, ma l’effetto è stupefacente. Audrey canticchia Moon River e io alzo il volume del Dolby Surround. I vicini protestano ed io faccio finta di niente. Com’è possibile che sia così deliziosa? Certo regale in Vacanze Romane, elegante in Cerenentola a Parigi, canterina in My Fair Lady, di classe in Sabrina, ma in questo film è diversa dal solito. Sarà pure la mano del regista.
Chi, quel burlone bistrattato da Hollywood di Blake Edwards? Sì, proprio lui che il pubblico ricorda per i film della Pantera Rosa. Non c’è niente da fare, la vita è fatta di incontri occasionali. Edwards non l’ho mai conosciuto, ma tanti anni fa in quell’aula universitaria incrociai una professoressa sopra le righe. Silvana Valerio mi disse papale papale: “Se vuoi amare il cinema, metti via i paraocchi e sali sulla giostra”. Tra i titoli di quella giostra c’erano La Pantera Rosa, Hollywood Party, SOB e Operazione Sottoveste. Fu allora che mi convinsi che nello studio come nella vita occorre cambiare i punti di riferimento, altrimenti si finisce nella solita gabbia, perché ognuno ti vorrebbe a sua immagine e somiglianza.
Intanto il film è terminato ed io mi chiedo cosa avessere in comune Blake Edwards e Audrey Hepburn. Essere due americani nati nel posto più sbagliato, perché sono più europei di tutti noi messi assieme. Mannaggia, inciampo nel buio senza accorgermi della notizia che esce dal pc: “Il regista Blake Edwards è morto a quasi novant’anni”. La solita burla! Forse la vera burla è un’altra, essermi trovato sotto l’albero di Natale tra Audrey Hepburn e Blake Edwards.