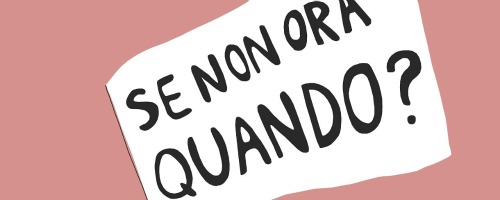Il sabato del “villaggio” incazzato: Il colle dell’Infinito di Leopardi in pericolo

![]() Ci sono paesaggi che la letteratura ha consegnato nelle mani dell’immaginario collettivo. Proteggere “l’ermo colle”, immortalato nei versi di L’infinito di Giacomo Leopardi, non è il sussulto di una protesta ambientalista né il desiderio degli stessi studentelli secchioni che imparavano Giacomo a memoria per portarsi a casa un bel voto.
Ci sono paesaggi che la letteratura ha consegnato nelle mani dell’immaginario collettivo. Proteggere “l’ermo colle”, immortalato nei versi di L’infinito di Giacomo Leopardi, non è il sussulto di una protesta ambientalista né il desiderio degli stessi studentelli secchioni che imparavano Giacomo a memoria per portarsi a casa un bel voto.
Ripensando al mio viaggio a Recanati nell’estate del 2012, mi interrogo: In Italia siamo un Paese così cialtrone e qualunquista da correre il pericolo di trasformare questo scorcio in una vista abominevole. Scampato il pericolo di un centro commerciale, finiremo a guardare bikini e culi intorno a una piscina, nella cornice di un casolare di campagna.
Al di là delle mobilitazioni social – in primis la raccolta di firme capeggiata dall’edizione online del quotidiano il Messaggero – mi vien da dire come i ministeri della Cultura dei nostri governi passati non si siano posti mai la questione, ovvero difendere quelle zolle di terra che riguardano ciascuno di noi. Se passate a Lecco tra i luoghi di I Promessi Sposi, vi accorgerete degli scempi fatti lungo la visuale dell’abbraccio di un ramo del lago di Como che evoca “L’addio ai monti” manzoniano.
“L’ermo colle” di Leopardi non è né della famiglia del poeta recanatese né di chi vuole costruirci una country house con ombrelloni e sedie a sdraio. Appartiene a tutti noi che, almeno una volta della vita, abbiamo cercato di acchiappare con quei versi l’Infinito. E forse sarebbe più giusto piazzarci un piccolo palco e lasciare ogni santo giorno poeti e cantautori declamare i propri versi. Del resto in pochi ce ne siamo accorti. Giacomo Leopardi ha anticipato lo stile delle ballate musicali dei nostri tempi e oggi sarebbe un inarrivabile paroliere di canzoni.





 Abbiamo perso di vista i sacerdoti di frontiera, coloro che sanno togliersi la tonaca al momento giusto e dar voce a chi l’ha persa. In uno dei miei recenti viaggi, ne ho ritrovato uno. Il volto di don Peppino Gambardella era a me noto e non perché fosse finito alla ribalta per aver digiunato a favore degli operai della Fiat di Pomigliano D’Arco. In un certo senso aveva sfiorato per pochi istanti la mia adolescenza, quando a quel tempo incantava gli allievi con le sue lezioni di filosofia.
Abbiamo perso di vista i sacerdoti di frontiera, coloro che sanno togliersi la tonaca al momento giusto e dar voce a chi l’ha persa. In uno dei miei recenti viaggi, ne ho ritrovato uno. Il volto di don Peppino Gambardella era a me noto e non perché fosse finito alla ribalta per aver digiunato a favore degli operai della Fiat di Pomigliano D’Arco. In un certo senso aveva sfiorato per pochi istanti la mia adolescenza, quando a quel tempo incantava gli allievi con le sue lezioni di filosofia.