5 consigli dal mio viaggio low cost in Islanda

All‘Islanda è toccato essere il Paese n.52 del mio giro del mondo. Ecco 5 consigli dopo il viaggio mozzafiato nell’isola europea magica e piena di sorprese
IN VIAGGIO IN ISLANDA CON REYKJAVIK EXCURSIONS

Da 50 anni hanno scritto la storia del trasporto e del turismo di Reykjavik e dintorni. Reykjavik Excursions è un marchio turistico a cui potete affidarvi appena atterate nella capitale islandese. Grazie al loro servizio Flybus (a partire da 24€ a corsa) potete raggiungere in 45 minuti Reykjavik dall’aeroporto internazionale e, con un supplemento aggiuntivo, avrete uno shuttle che vi porterà poi direttamente all’alloggio indicato.
Noleggiare l’auto in Islanda può arrivare a costare tre volte rispetto all’Italia. Partire da Reykjavik con tour organizzati in mini van con guide specializzate può essere un’alternativa intelligente e avere un buon rapporto qualità prezzo. Reykjavik Excursions vi propone 128 tour in Islanda per tutte le tasche che vi consentiranno di costruire itinerari personalizzati. Monitorate le offerte dal sito e prenotate in largo anticipo, soprattutto ora che si va verso il periodo di alta stagione.
L’AVVISTAMENTO DELLE BALENE CON ELDING WHALE WATCHING

Chi non ha mai sognato di vedere una balena? Io fin da bambino, dai tempi dell’infanzia in cui papà la sera mi raccontava a puntate la favola di Pinocchio. Affidatevi per vivere questa incredibile esperienza all’equipaggio di Elding Whale Watching. Dal porto di Reykjavik tutti i giorni partono le loro imbarcazioni per l’avvistamento delle balene. In caso il whale watching non dia i risultati sperati, Elding Whale Watching vi offre una seconda opportunità. Prenotate con anticipo sul sito. A bordo salvagente e binocolo per tutti!
Inoltre, vi consiglio anche l’avvistamento dei Puffin, buffi pennuti simbolo dell’Islanda e del Nord Europa conosciuti in Italia con il nome di Pulcinella di mare.
IN BARCA NELLA LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON

Jökulsárlon, uno dei ghiacciai simbolo del Nord Europa, resta la perla del Sud dell’Islanda. Una volta arrivati in questo paradiso naturalistico, non potete fare altro che salire sull’imbarcazione di Glacier Lagoon.
Con un’esperienza di 25 anni, l’equipaggio vi porterà alla scoperta di una laguna glaciale che vi toglierà il fiato. Salvagente per tutti e se siete fortunati come me avvisterete anche delle simpatiche foche.
Vi consiglio l’Amphibian Boat Tour della durata di 35 minuti. Anche in questo caso, per non rischiare di fare un lungo viaggio a vuoto, vi suggerisco di prenotare in anticipo.
MANGIARE ISLANDESE AL REYKJAVIK ROST

Un posto delizioso e pieno di atmosfera è il Reykjavík Röst, coffee house sul porto della capitale che serve anche piatti tipici islandesi con un buon rapporto qualità-prezzo. Fatevi consigliare da Agnes, che gestisce con passione e dedizione questo localino aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18.
Il mio tragitto nella cucina islandese è stato fatto da un assaggino di carne di squalo, un tagliere di formaggi locali accompagnato da pane abbrustolito, dell’ottimo salmone affumicato su un tappeto di pane e insalata e una birra locale accanto al camino.
Ci sono tornato anche una mattina a colazione, seduto alla finestra con vista sull’oceano. Agnes mi ha preparato un buon caffè americano e una crepe con della crema tipica islandese. A pranzo è sempe pieno, perciò meglio prenotare. Se siete in gruppo, fatelo presente!
NOSTALGIA DELLA CUCINA ITALIANA A GRAZIE TRATTORIA

Nostalgia, nostalgia canaglia della cucina italiana, che ti prende proprio quando non vuoi? Ho scoperto con il mio fiuto da reporter e viaggiatore Grazie Trattoria, un bel ristorante a Reykjavik in Hverfisgata 96, inaugurato qualche mese fa.
La passione dell’islandese Kristján Nói per il cibo italiano ha dato vita a questo ristorante dal design d’interni che esalta la nostra arte italiana e i piatti cucinati con prodotti tipici nostrani. In Islanda nella nostra amata pasta alla carbonara ci mettono pancetta e crema di formaggio. In quella da me assaggiata c’era del vero guanciale e pecorino romano proveniente dalla nostra bella Italia. Vi consiglio anche l’ossobuco con una delicata crema di polenta e, come dessert, avete l’imbarazzo della scelta tra tiramisù e panna cotta.
Infine Kristján, l’islandese innamorato della cucina italiana, mi ha fatto assaggiare il suo limoncello di cui è tanto fiero. Preparato con i limoni della Sicilia, Islenskt Limoncello è distribuito in venti ristoranti della capitale.












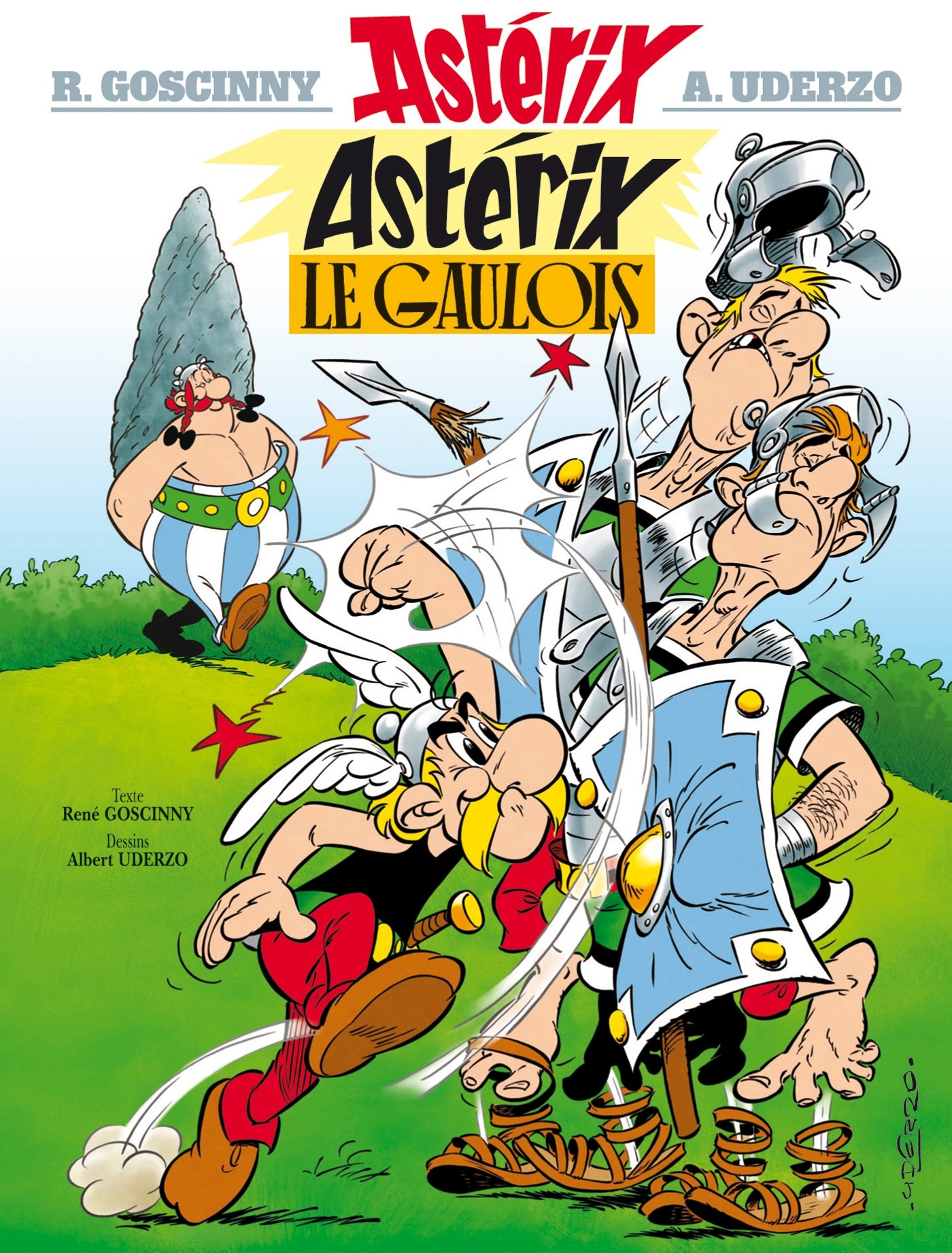





 Lorena arrivò in Alaska nel 1965 ancora in fasce. Anchorage, l’ultima città del mio incredibile viaggio nell’ultima frontiera, ha fatto da ponte di collegamento con tutto il Centro e Sudamerica, accogliendo tante famiglie immigrate. Lorena è di origine messicana, è cresciuta qui e oggi fa l’artigiana: veste con pelliccia bambole eschimesi che sono per me un souvenir fatto a mano da portar via da un luogo sempre snobbato, perché considerato poco alaskino.
Lorena arrivò in Alaska nel 1965 ancora in fasce. Anchorage, l’ultima città del mio incredibile viaggio nell’ultima frontiera, ha fatto da ponte di collegamento con tutto il Centro e Sudamerica, accogliendo tante famiglie immigrate. Lorena è di origine messicana, è cresciuta qui e oggi fa l’artigiana: veste con pelliccia bambole eschimesi che sono per me un souvenir fatto a mano da portar via da un luogo sempre snobbato, perché considerato poco alaskino.