
 Da quando sono nato, a Napoli mi fanno puntualmente la stessa domanda: “Sei parente di Oreste il fotografo?”. Ai tempi del liceo mi spinsi fino al suo studio fotografico in via Carbonara, per conoscere il fantomatico Oreste Pipolo con cui spartivo il cognome senza un legame di parentela.
Da quando sono nato, a Napoli mi fanno puntualmente la stessa domanda: “Sei parente di Oreste il fotografo?”. Ai tempi del liceo mi spinsi fino al suo studio fotografico in via Carbonara, per conoscere il fantomatico Oreste Pipolo con cui spartivo il cognome senza un legame di parentela.
Non fu quella l’occasione. Sarebbe arrivata anni dopo, prima del mio trasferimento a Milano, mangiando una pizza da Michele. Era seduto a fianco a me. Dopo le presentazioni, Oreste Pipolo tiro giù gli occhialini e mi disse scherzosamente: “Ora ti riconosco. Tu se il giornalista che mi ha fregato il dominio Pipolo.it”.
Più che “fotografo di matrimoni” – come recita il bel documentario che Matteo Garrone gli tributò – Oreste Pipolo è stato l’antropologo delle spose napoletane. Le osservava con occhio critico e le denudava da tutti i vezzi pacchiani, di cui molti dei suoi colleghi ne fanno un vanto, prima e dopo il servizio fotografico da matrimonio, per immortalare così le principessine cafone di mammà e papà.
Tutte le spose, raccontate dall’obiettivo stilografico di Pipolo, diventavano la polvere di stelle con cui era stata creata Napoli dal Padreterno: non erano colte nella finta bellezza, che popola la maggior parte delle sposine “photoshoppate” ammucchiate sugli album dell’era digitale, ma in un misto di imperfezioni, lapilli poetici della bruttezza insidiata in ciascuno di noi. Perciò il matrimonio raccontato da Pipolo si staglia netto da ispirazione per il cinema.
Alla fine degli anni ’90 avevo conosciuto un gruppo di matrimonisti pugliesi che, dopo aver fatto un seminario con l’artista napoletano, mi dissero: “Osare come Oreste nella scelta degli scenari, significa non lavorare dalle nostre parti. Qui da noi le spose vogliono il ritratto accanto al mobiletto della mamma. E’ una malattia cronica del Sud”.
Il destino delle spose di Oreste Pipolo, per fortuna nostra, fu lo scatto su i binari dismessi della stazione di Gianturco o sotto un’arrampicata dei Quartieri Spagnoli, per essere misteriosamente velo della Napoli che nasconde la bellezza principesca sotto i cenci di una gatta cenerentola.
Evocando la sposa felliniana nel film Amarcord, avrei voluto un’ultimo scatto nel portfolio di Oreste Pipolo: una sposa scalza sulla spiaggia abbandonata di Coroglio, tra il lido Pola sbarrato dove si conobbero i miei genitori e il tanfo di catrame dell’ex Ilva di Bagnoli che arrivava fino alla finestra dei miei nonni. Nella tessitura visiva immaginata, accanto alla donna col velo, lo sposo volevo essere io.

















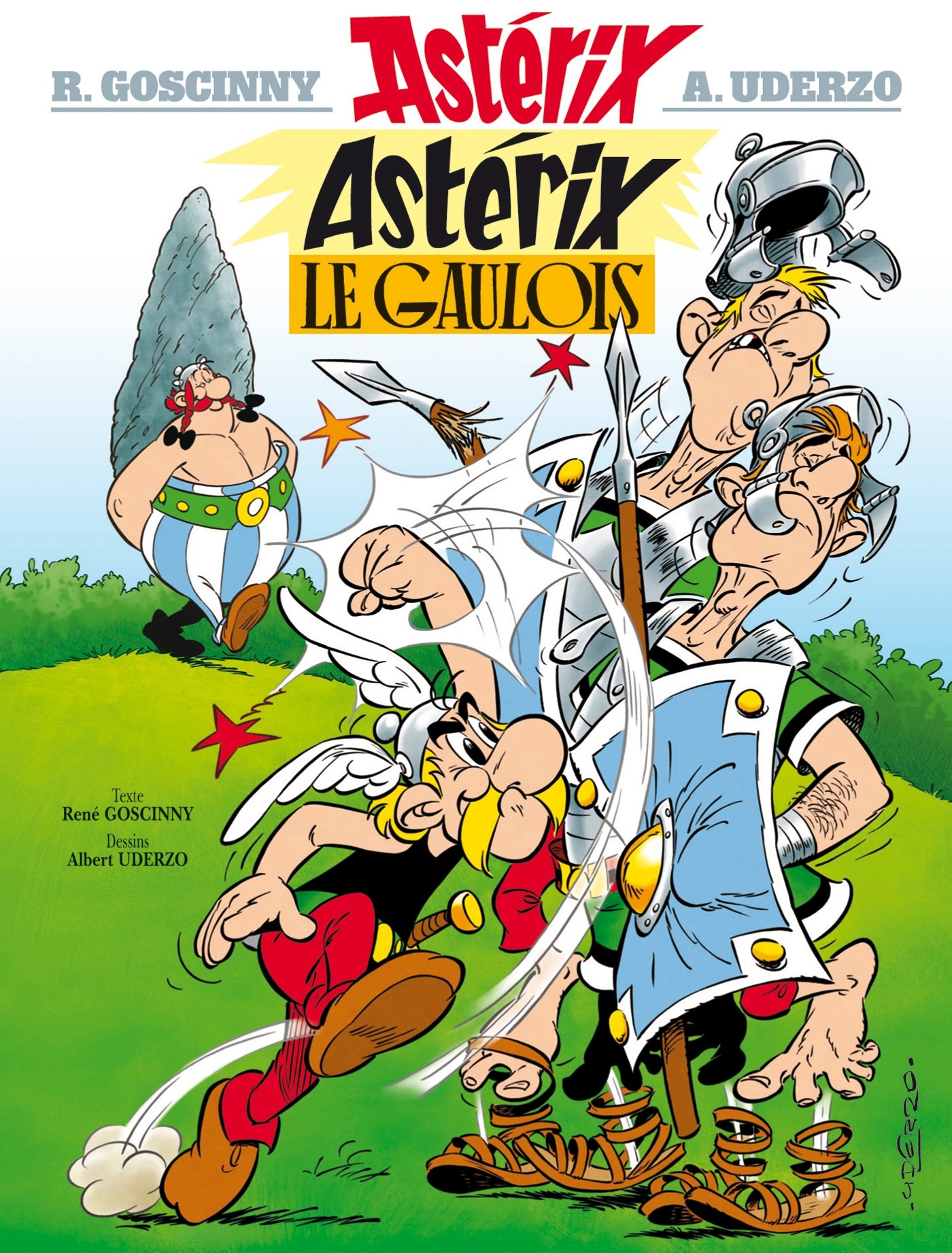


 Facendo due conti, l’anno scorso io ritornavo a New York dopo 23 anni ed Elisa Pasino intingeva la penna nel calamaio per cominciare a scrivere la sua guida New York al femminile, edita da Morellini. Che gusto retrò ha questa immagine della penna nel calamaio oggi che abbiamo digitalizzato tutte le dita della mano.
Facendo due conti, l’anno scorso io ritornavo a New York dopo 23 anni ed Elisa Pasino intingeva la penna nel calamaio per cominciare a scrivere la sua guida New York al femminile, edita da Morellini. Che gusto retrò ha questa immagine della penna nel calamaio oggi che abbiamo digitalizzato tutte le dita della mano.



