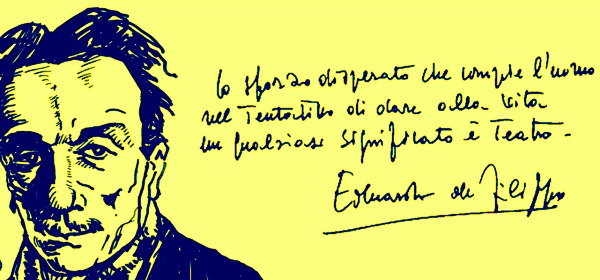DIECIANNI

Io l’ho vista rannicchiata in un fazzoletto di periferia alle falde del monte Somma e me ne sono innamorato. Il 9 novembre, in coincidenza con il suo sesto compleanno, aveva spezzato in due i miei vent’anni portandomi via nonno Pasquale. Quel giorno di immenso dolore sarebbe diventato, anni e anni dopo, giorno d’amore perché la vita sa come muovere i fili del destino.
Diecianni come il frammento di un sonetto che la polvere del tempo non ha intaccato, diecianni come il titolo di un cortometraggio proiettato sulla parete della nostra distanza anagrafica.
Io l’ho vista al di là dei suoi occhialini rettangolari dietro cui si nascondeva, l’ho baciata sul calar della sera nei pressi di una scuola di periferia, ho capito che chissà quando l’avrei portata all’altare. Lei non sapeva di essere per me quello che Mary era stata per George nel bianco e nero argentato del film La vita è una cosa meravigliosa. Io l’ho vista lunatica, intimidita, arrossire, ridere, piangere, farsi in quattro per la sua famiglia, arrabbiarsi, lanciare il lazzo della sua generosità, soffiare le candeline di compleanno sotto la Torre Eiffel su una tortina presa al supermercato.
Diecianni come i bambini che accudiva in una casa famiglia in provincia di Napoli, diecianni come le sue paure di trasferirsi per amore in un posto che non era il suo, diecianni come la porta lasciata socchiusa quando se n’è andata. Io sapevo che, in un giorno lontano di primavera, sarebbe ritornata. Ho aspettato nel più tremendo silenzio.
Io l’ho vista sbucare in abito bianco verso di me, raggiante e felice come una principessa scalza di altri tempi, in punta di piedi e senza clamori, perché una promessa d’amore non fa rumore al cospetto di Dio. Io l’ho vista farsi impavida viaggiatrice dall’altra parte del mondo, nel quinto continente, nei 40 giorni del “viaggio dei viaggi”, il nostro, quello che ha ridisegnato le tappe della nostra vita insieme tra dune bianche, koala, wallaby e quokka, sterminati deserti rossi, barriere coralline, mescolanza con Aborigeni e Maori, voli e navigazioni, oceani.
Diecianni come la crescita insieme sconfiggendo paure e insicurezze, diecianni come le nostre diversità e visioni della vita contrastanti, diecianni come le radici del nostro Sud comune attaccate per sempre alla quercia della vita.
Io l’ho vista prendersi cura amorevolmente del padre nella Genova di Fabrizio De André, farsi in quattro per realizzare il sogno di una casa nuova che prendesse le sembianze delle nostre anime, impacchettare (per amore) migliaia e migliaia di vecchi dischi e souvenir di viaggio da ogni angolo del pianeta, commuoversi all’ombra della Madonnina su un tramonto che accendeva Milano di rosso. Io l’ho vista uscire di casa prima dell’alba per attraversare la Lombardia e correre dai suoi bimbi in un asilo nido di provincia, rincasare la sera con le borse della spesa mentre ero ammalato.
Diecianni come i suoi occhi lucidi davanti alle lapidi gelide dei soldati mandati a morire nella Grande Guerra, diecianni come il futuro che innalza la vita insieme alla pagina di un romanzo, diecianni come il suo stupore per la bellezza delle Alpi sulla strada delle fughe piemontesi verso il Lago Maggiore o il suo “friccico” per i preparativi natalizi tra addobbi e piatti della tradizione da lei preparati.
E lei che il 9 novembre di dieci anni fa, nel giorno del suo compleanno, pensava di aver baciato il principe azzurro, si è ritrovata, prima come fidanzato e poi come marito, “un principe scugnizzo” ribelle e vagabondo, strafottente e romantico, che ha fatto della libertà l’asfalto della strada per attraversare la vita tra cadute e risalite.
Diecianni come gli errori commessi perché gli esami non finiscono mai per chi vuole imparare ad amare, diecianni come il bello e il cattivo tempo di questa incredibile storia d’amore, diecianni come i sogni di un ragazzo e una ragazza della periferia di Napoli.
10 anni, oggi 9 novembre, di me e Luisa, una carezza nel cosmo dell’eternità.




 Se incontrate Greta Menchi, la YouTuber che ha scatenato la sommossa sui social per essere finita nella giuria degli esperti del 67° Festival di Sanremo, raccontatele chi era Claudio Villa.
Se incontrate Greta Menchi, la YouTuber che ha scatenato la sommossa sui social per essere finita nella giuria degli esperti del 67° Festival di Sanremo, raccontatele chi era Claudio Villa.