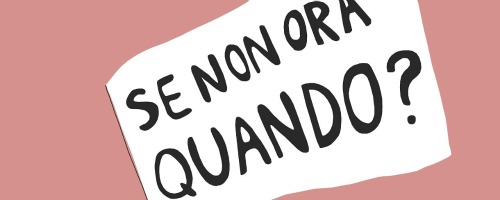Ospito sul blog il testo integrale dell’intervento di Massimo Calanca, in occasione della presentazione a Roma del mio libro “L’ultima neve alla masseria” presso la sede dell’Associazione Centro Internazionale CinemAvvenire.
Mi fa piacere presentare il libro “L’ultima neve alla masseria”, perché Rosario Pipolo è stato uno dei primi partecipanti alle iniziative di CinemAvvenire alla Mostra del Cinema di Venezia. La nostra iniziativa veneziana ha avuto fin dall’inizio l’obiettivo di trasmettere ai giovani, attraverso l’arte cinematografica, non solo la conoscenza e l’amore per un cinema “che aiuta a capire la vita ed a viverla meglio”, come diceva Gillo Pontecorvo, il maestro che ha fondato insieme a noi l’associazione; ma anche il desiderio e il piacere della creatività, applicata sia all’arte vera e propria, sia alla propria esistenza individuale, “per fare della propria vita un’opera d’arte”, come ha detto Antonio Mercurio, il maestro a cui si è ispirato gran parte del nostro lavoro di psicoterapeuti.
Il libro di Rosario è un misto tra l’autobiografia e il romanzo. Lo potrei definire una ricerca autobiografica di fantasia. A ben vedere, ogni opera d’arte è in qualche misura autobiografica, anche se parla di mondi lontani dall’esperienza di vita dell’autore, perché questi non può fare a meno da un lato di mettere dentro l’opera se stesso e la propria esperienza di vita, e dall’altro di ricercare un senso alla propria vita addentrandosi nei pensieri e nelle vicende dei personaggi di finzione. Ha scritto Luigi Pareyson: “L’arte è l’attività formativa per eccellenza….. La persona dell’artista è al tempo stesso “contenuto” e soggetto formante; mentre, nell’interpretazione, la persona del fruitore “si fa organo di accesso all’opera e, rivelando l’opera nella sua natura, esprime nel contempo se stessa”. E poiché la vita umana è tutta invenzione, produzione di forme, “l’arte modifica la nostra capacità formativa e quindi lo stesso nostro modo di vedere e formare la realtà e la vita.” (L. Pareyson, Teoria delle formatività”).
Ma, se ogni opera è in qualche modo autobiografia, esistono tuttavia opere, come questa di Pipolo, più chiaramente e direttamente figlie del pensiero autobiografico. Capita a tutti, prima o poi, di sentire il bisogno di ripensare alla propria vita passata e di raccontarsela e raccontare se stessi a se stessi (e qualche volta agli altri) in modo diverso dal solito. E’ quello che viene chiamato “pensiero autobiografico” (Duccio Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore). “Il momento in cui sentiamo il desiderio di raccontarci è segno inequivocabile di una nuova tappa della nostra maturità. Poco importa se ciò accada a vent’anni piuttosto che a ottanta. E’ l’evento che conta, che sancisce la transizione a un altro modo di essere e di pensare.” (Ivi.) Il pensiero autobiografico è quell’insieme di ricordi della propria vita trascorsa, di ciò che si è stati e che si è fatto, che ripercorriamo in cerca di un nuovo senso. Anche quando tale pensiero si rivolge verso un passato doloroso, di errori o occasioni perdute, è un’occasione di un “ripatteggiamento”, di una riconciliazione, a volte con sentimenti di maliconia o di compassione, ma comunque di rappacificazione con se stessi. “Ciò che è stato poteva forse compiersi altrimenti, la storia potrebbe aver avuto altri finali, ma, comunque sia, ora quella storia è ciò che è. E si tratta di cercare di amarla, poiché la nostra storia di vita è il primo ed ultimo amore che ci è dato in sorte” (Duccio Demetrio, op. cit.).
Paradossalmente questo non ci porta alla chiusura individualista o egocentrica, ma al contrario ci aiuta a sentire che condividiamo l’essere al mondo di tutti gli altri. Il pensiero autobiografico in qualche modo ci cura. Mentre ci rivediamo alla moviola (“sviluppiamo i negativi della nostra vita”, come ha detto Marcel Proust), ci riprendiamo tra le mani, “ci prendiamo in carico (in cura) e ci assumiamo la responsabilità di tutto ciò che siamo stati o abbiamo fatto e, a questo punto, non possiamo che accettare” (D: Demetrio). Ma questo non significa rassegnazione. Da un lato significa accettazione, cioè amore per noi stessi. Dall’altro può significare decisione di cambiare o di lasciare andare qualche parte di noi, proprio alla luce dell’esperienza passata rivisitata, meglio compresa e “metabolizzata”. Cioè è un’occasione di trasformazione esistenziale che guarda al futuro.
Infatti il ricordo non è mai soltanto un semplice rivivere il passato. Da un lato, certo, è una riedizione, cioè ci fa rivivere, mentalmente ed emozionalmente, situazioni già vissute, che ci richiamano e ci legano in qualche modo al passato, e a volte rischiano di farci rimanere dentro il circolo vizioso della “coazione a ripetere”. Dall’altro, poiché noi non siamo più quelli di un tempo ed inoltre il nostro Sé ci spinge ad evolvere e a crescere, il ricordo è sempre qualcosa di rivisitato, di nuovo, di diverso, di inventato, che già contiene in parte quello che siamo diventati oggi e quello che vogliamo diventare domani.
L’autobiografia non va intesa come una specie di farmaco che ci aiuta a liberarci dal nostro passato prendendone le distanze. Questo può valere in parte per le situazioni traumatiche che abbiamo rimosso o dimenticato, di cui fatichiamo a prendere coscienza, e che quindi ci condizionano senza che ne siamo consapevoli. Allora, rivisitarle con il ricordo e oggettivarle con l’autobiografia, può servire non a liberarsi di loro, ma a liberarsi del conflitto inconscio che continuano a generare, per integrarle armoniosamente nella nostra personalità. “L’autobiografia non è soltanto un tornare a vivere: è un tornare a crescere per se stessi e per gli altri…è un viaggio formativo e non un chiudere i conti” (D. Demetrio). “Io pongo il mio passato come mio avvenire, mi sottraggo alla minaccia della dispersione e stabilisco l’unità e la coscienza del mio io” (Nicola Abbagnano, “Introduzione all’esistenzialismo”, Mondadori).
“E’ vero che scruto nel mio passato per trovare chi sono, da dove vengo, chi mi ha aiutato ad essere ciò che poi sono divenuto; però è pure vero che, già con quest’opera di scavo, mi apro al mondo, ad altre possibilità” (D. Demetrio). “Entrare in autobiografia” (come la definisce Vincenzo Masini) è superare la paura del tempo, perché l’atto autobiografico è sempre al presente. S. Agostino, nel suo interrogarsi sul tempo, scrive: “… Futuro e passato non esistono… impropriamente si dice: tre sono i tempi, il passato, il presente e il futuro. Più esatto sarebbe dire: tre sono i tempi: il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro. Queste ultime tre forme esistono nell’anima … il presente del passato è la memoria, il presente del presente è l’intuizione diretta, il presente del futuro è l’attesa.” (S. Agostino, Le confessioni) Lo stesso poeta Gibran non si allontana da S. Agostino quando, interrogato sul tempo, risponde: Vorreste misurare il tempo, l’incommensurabile e l’immenso. Vorreste regolare il vostro comportamento e dirigere il corso del vostro spirito secondo le ore e le stagioni. Ma l’eterno che è in voi sa che la vita è senza tempo. E sa che l’oggi non è che il ricordo di ieri, e il domani il sogno di oggi.
Ma se col pensiero volete misurare il tempo in stagioni, fate che ogni stagione racchiuda tutte le altre. E che il presente abbracci il passato con il ricordo, e il futuro con l’attesa.” (Kahil Gibran, Il profeta). Come è noto, il concetto di Sé è molto importante in psicoterapia. Un elemento caratterizzante del Sé è il suo manifestarsi in forma narrativa. Ha scritto lo psicoanalista junghiano Robert H. Hopcke: Essere umani significa raccontare storie, vivere e usare dei simboli per dare senso alla nostra vita, cercare un’esperienza profonda e diretta di ciò che trascende la nostra limitata esistenza mortale…(Robert H. Hopcke, Nulla succede per caso. Le coincidenze che cambiano la nostra vita, Mondadori, Milano, 1998). Scrive Andrea Smorti, uno psicologo cognitivista che ha studiato il pensiero narrativo: “Che cosa è il Sé? Non è facile definirlo. Ce lo possiamo però rappresentare come un testo che giorno dopo giorno viene scritto dal soggetto stesso e dagli altri”.( Andrea Smorti, Il Sé come testo. Costruzione di storie e sviluppo della persona, Giunti, Firenze, 1997. Il corsivo è mio)
Lavorare alla propria autobiografia non significa soltanto affastellare insieme una serie di ricordi che emergono alla mente alla rinfusa, ma anche ricercare le connessioni, i nessi, le coerenze tra i ricordi, ricomponendoli in figure, disegni, architetture. Ogni singolo ricordo è un segno, che ha “graffiato” la nostra vita come una lastra da incisioni, ma appartiene ad una rete che tende a ricomporlo in una scena, in una storia dotata di senso. La mente non si limita a rievocare immagini tra loro isolate e distinte. L’intelligenza retrospettiva ricostruisce, collega e quindi colloca nello spazio e nel tempo, riesce a dar senso agli eventi solo se li colloca in un processo e in un percorso. L’autobiografia, sia quella che rimane ad uso personale, sia quella che ha ambizioni letterarie, viene scritta perché l’autore ha bisogno di attribuirsi un significato, e forse più di uno, e di presentarsi in modo nuovo a se stesso e, qualche volta, al mondo.
Ma ho detto che il romanzo di Rosario Pipolo è anche fatto di immagini fantastiche. Sia nella storia che il protagonista racconta di sé, dei suoi familiari e della sua terra, sia in alcuni dei personaggi tra il reale e l’onirico che incontra nel suo ritorno a casa, sia nella sua ricerca documentaria delle proprie origini, a figure della realtà, che hanno il sapore inconfondibile del vissuto personale nella terra e nella cultura del suo paese, si mescolano immagini della fantasia. Lo stile di questo “melange” mi ricorda quello del Fellini di “Otto e ½” o di “Amarcord”, film dove realtà, sogno, immaginazione e prefigurazione, si inseguono sulla base di associazioni più analogiche che logiche, più emozionali che razionali; anche se l’insieme finisce per comporre un “puzzle”, o meglio un affresco, in cui pian piano emerge il senso faticosamente cercato dal protagonista e dall’autore riguardo la propria opera e la propria vita. Ho pensato che non a caso Rosario, anni fa, si è impegnato nel progetto “Fellini 2000”, evento omaggio al grande regista, realizzato in collaborazione con la Fondazione Fellini e Mediaset.
Ma, al di là delle suggestioni e dei rimandi, la parte fantastica del romanzo di Pipolo è altrettanto, se non più, interessante di quella del ricordo reale per la ricerca di senso di cui sto parlando. Infatti, la fantasia – quando non è impacciata da intenti didascalici o dimostrativi, ma si esprime con associazioni libere guidate da autentiche emozioni – è capace di illuminare di senso e di nuovo significato fatti, eventi e situazioni che nella semplice ricostruzione del vissuto ci appaiono inesplicabili ed oscuri. E’ il potere del pensiero primario, che attraversa facilmente nei due sensi il confine tra l’inconscio e la coscienza, mettendo in comunicazione mondi separati e diversi e creando collegamenti e nessi che mettono in luce aspetti nuovi e significati inediti di eventi, cose, persone.
E infatti è dall’intreccio di ricordi reali e fantastici che emerge a poco a poco il senso che Pietro, il protagonista, ritrova. Non è tanto importante portare fino in fondo la ricerca delle radici reali, quanto metabolizzare i ricordi del passato integrandoli nella propria personalità unificata, filtrandoli e risanandoli, affinché non ingorghino il futuro, attraverso il sogno del padre, “quell’ultima neve alla masseria” rimasta ancora intatta nonostante il degrado del tempo e di uno sviluppo sociale ed economico senz’anima. Discorso che io interpreto così, nel mio linguaggio La ricerca di senso è indispensabile per uscire dal nichilismo disperante. La distruzione di tutti i valori operata dalla razionalità occidentale, se da un lato ci ha liberato da schemi mentali e di comportamento limitanti e spesso soffocanti, aprendoci a nuove possibilità di libertà, dall’altro ci ha privato di ogni punto di riferimento e, soprattutto, del senso e del significato della realtà e della vita. Sembra che manchi il motivo e la direzione del nostro agire e del nostro stesso stare al mondo. E ciò, al di là dell’illusione di riempire questo vuoto con il consumo, con “quell’edonismo di massa” di cui ha parlato Pasolini, non può che produrre disperazione.
Ma davvero la ragione deve limitarsi a togliere senso? – si è interrogato Eugenio Scalfari. – Non potrebbe invece avere un’autonoma capacità di dare senso e valore, cioè contrastare il nichilismo con le forze dell’illuminismo invece che con quelle del mito? Secondo me, da sola, la ragione non basta, anche se può dare un grande contributo a questa ricerca. Occorre addentrarsi anche nei territori oscuri dell’inconscio, degli archetipi, dei miti; confrontarsi con le parti oscure che ci abitano come esseri umani, nei ricordi personali della nostra infanzia ma anche in quelli ancestrali della specie che sono stampati dentro di noi. Contrastare la rimozione e l’oblio, per portare queste parti alla luce, non per eliminarle in quanto parti oscure, ma per unificarle con le nostre parti luminose e diventare così persone intere.
In fondo ogni opera d’arte è il frutto di una sintesi di opposti. Questo vale sia per l’arte vera e propria, sia per l’opera d’arte della nostra vita. E ognuno di noi oggi deve fare questo percorso in parte insieme agli altri, cioè ai personaggi del suo passato, del suo presente e del suo futuro, perché “l’Io senza il Tu non esiste”, come ha detto Martin Buber. Inoltre deve farlo riallacciando i nessi con il padre, con quel “principio paterno” che è insieme garanzia di radicamento nella storia evolutiva dell’uomo e prospettiva di ulteriore evoluzione verso nuove proprietà emergenti dello spirito. Ma, nella “Babele” del mondo contemporaneo, è inevitabile che ognuno debba fare questa ricerca in parte anche da solo.
E’ quello che mi pare dica il libro di Rosario Pipolo alla fine. E in questo mi pare in piena sintonia con quanto ha scritto Joseph Cambell, il grande mitologo americano: “è il cuore dell’uomo (e della donna) oggi il luogo creativo del mito moderno, il centro focale dello sguardo divino”. Di “quel Dio che in parte siamo noi e che in parte dobbiamo ancora diventare”, come ha scritto Antonio Mercurio. Senza deliri di onnipotenza, perché non nasciamo dal nulla ma veniamo dalla materia e dalla vita che agiscono secondo leggi che ci precedono. Ma anche senza rinunciare alla responsabilità che ci compete, quantomeno come co-autori della creazione nostra e del mondo in cui viviamo.
Roma, 13 aprile 2013
Massimo Calanca*
Psicologo e psicoterapeuta
* Nato a Roma nel 1947, è stato segretario nazionale dell’ARCI, organizzando tra l’altro la tournèe dei fratelli Taviani in America Latina, il viaggio di Gillo Pontecorvo in Nicaragua ed in Salvador alla ricerca delle idee per un film e fondando la ONG di cooperazione allo sviluppo Arci-Cultura e Sviluppo. Laureato in lettere moderne, si è specializzato in comunicazione sociale. Nel 1992 ha fondato con Gillo Pontecorvo alla Mostra del Cinema di Venezia l’associazione CinemAvvenire, per promuovere l’amore e la conoscenza del cinema tra i giovani e gli studenti, divenendone presidente alla scomparsa del fondatore. Vive e lavora a Roma, dove si occupa di psicoterapia, counseling e formazione.

 Le cose che non ci siamo detti mai le ritrovo qui, fuori le mura di questa caserma, nel perimetro dela Cecchignola di Roma, e non di certo perché abbia fatto la naia. Nei miei venti giorni con la divisa risultai il militare più indisciplinato e ribelle, senza che nessuno scommettesse fossi il nipote di un maresciallo dell’esercito.
Le cose che non ci siamo detti mai le ritrovo qui, fuori le mura di questa caserma, nel perimetro dela Cecchignola di Roma, e non di certo perché abbia fatto la naia. Nei miei venti giorni con la divisa risultai il militare più indisciplinato e ribelle, senza che nessuno scommettesse fossi il nipote di un maresciallo dell’esercito.










 Sono una minoranza gli adolescenti che si fanno travolgere dalla musica fuori dal proprio tempo. Mi sentivo parte di questo branco ristretto quando alla fine degli anni ’80 me ne andavo nei paesotti di provincia a cercare i tuoi dischi, caro Richard. Una volta girando a Liverpool – ero ancora minorenne e lasciai i miei in preda alle palpitazioni – nei posti in cui sei cresciuto, mi sono detto: cosa avevamo in comune? Anche tu eriun ragazzotto di periferia e non penso che, picchiando forte sulla tua batteria, avresti mai immaginato di attraversare il mondo.
Sono una minoranza gli adolescenti che si fanno travolgere dalla musica fuori dal proprio tempo. Mi sentivo parte di questo branco ristretto quando alla fine degli anni ’80 me ne andavo nei paesotti di provincia a cercare i tuoi dischi, caro Richard. Una volta girando a Liverpool – ero ancora minorenne e lasciai i miei in preda alle palpitazioni – nei posti in cui sei cresciuto, mi sono detto: cosa avevamo in comune? Anche tu eriun ragazzotto di periferia e non penso che, picchiando forte sulla tua batteria, avresti mai immaginato di attraversare il mondo.